di The Cherry Pies
2024 – The Cherry Pies
Durante il primo lockdown, fino a quando si è potuto, sono andato a correre tutti i giorni.
Era un modo per evadere, certo, ma era anche un modo per ascoltare musica con tranquillità, cosa che tra le quattro mura di casa, occupate da una famiglia invadente, non riuscivo a fare. In quelle settimane entrai parecchio in fissa con un determinato genere musicale, il garage punk/rock, che meglio di tutto il resto riusciva a trasmettermi libertà.
Il disco che più ascoltai era il terzo lavoro in studio dei Bee Bee Sea, Day Ripper, che da quei giorni è diventato un culto personale.
Come ho detto, però, entrai proprio in fissa con il genere, riuscendo ad avvicinarmici sempre più grazie al tempo e agli album ascoltati.
Adesso, poco più di quattro anni dopo, entro di nuovo in fissa con un disco dai suoni simili, forse più dolci e più folk, a quello dei Bee Bee Sea, ma con lo stesso impatto e con la stessa sensazione trasmessa: libertà.
I Cherry Pies Sono in quattro: Veronica Zucca, Stefano Isaia, Nicola Lotta e Riccardo Salvini (di cui abbiamo già parlato a proposito degli Indianizer).
Da quel che ho letto in giro il loro primo album, omonimo, fu registrato solamente da due componenti della band con l’ausilio di un vecchio Mac durante il primo lockdown ed uscì poi in vinile per l’australiana Spooky Records e la francese Beast Records, che ha deciso di produrre anche il loro nuovo album di cui stiamo parlando ora.
Sulla loro pagina Bandcamp scrivono di essere una bittersweet band il cui sound attinge a piene mani dal garage punk (appunto) e dal folk americano. Si passa dal rock alle ballate in un amen con le voci di Veronica e Stefano che si alternano e convivono nei ritornelli in maniera soave. Come le chitarre, che spingono quando c’è da spingere e coccolano quando si passa alle ballate. Lente, dolci, anche quando parlano d’amori che finiscono (a tal proposito Little Suzy è una canzone stupenda).
I Cherry Pies si affidano indiscutibilmente al mondo americano, e questo lo si può dedurre dalla copertina. In generale, ascoltarlo è come guidare su una di quelle larghe strade che percorrono la costa della California, magari il Big Sur.
L’America un po’ vintage, quella dei Beach Boys, degli Everly Brothers, di Roy Orbinson, ma anche decadente come l’hotel abbandonato sulla copertina. Un po’ inquieta, ma che si abbandona volontariamente a quel disagio, fa il giro e diventa un tributo all’american dream. Si è soli su una strada dimenticata, la luna emana una luce rossastra, ferita come da un coltello, e illumina la pianura. Fa paura, ma trasmette libertà.
Don’t Just Say Things, appunto. Lo dico, lo ripeto, facciamo parlare la musica che è meglio. Siamo liberi e va bene così.
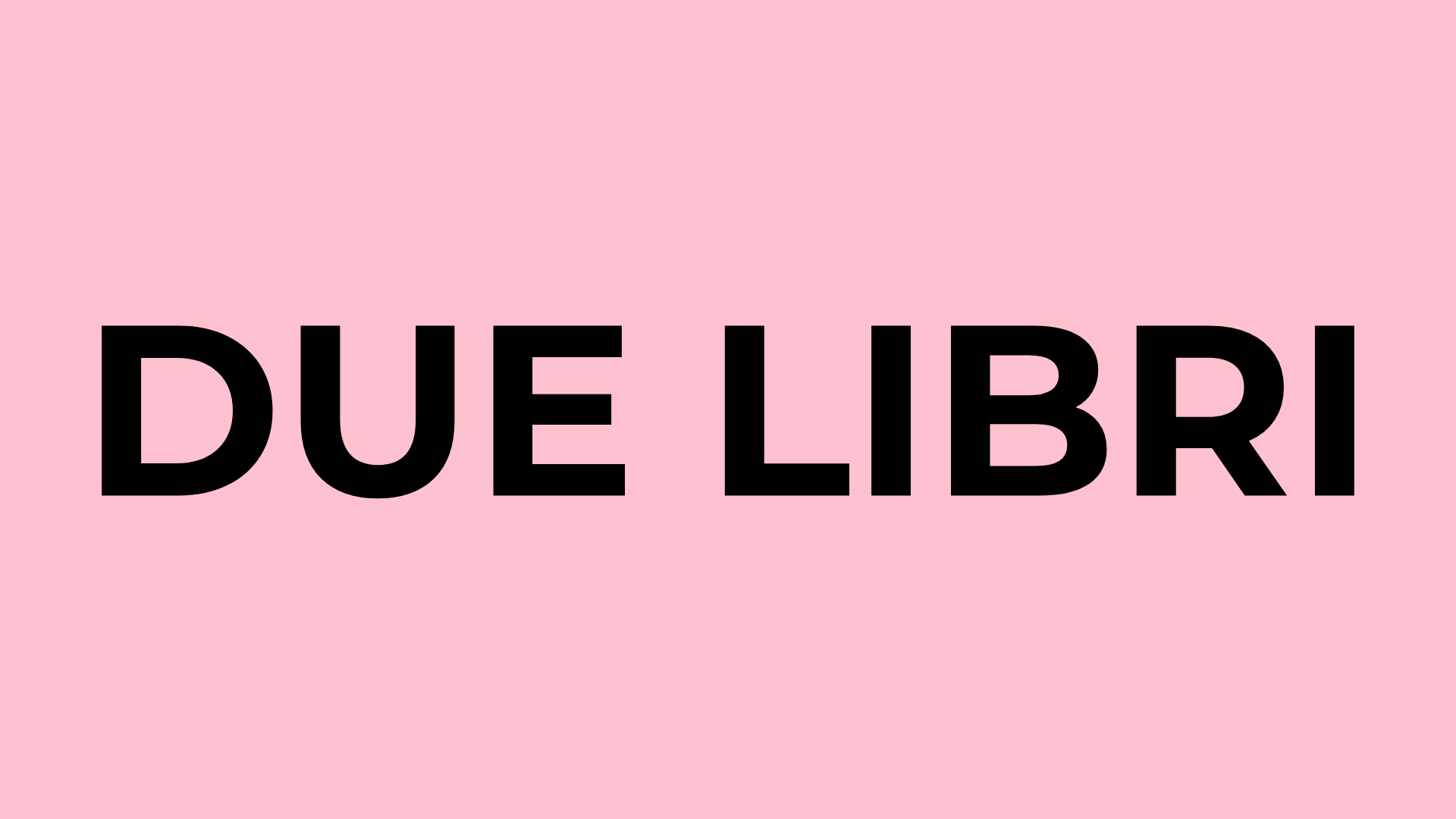

Lascia un commento