di Molly Manning Walker – 2023
Disponibile su MUBI
Come succede ad ogni cinefilo, mi è capitato di scrivere uno di quei papiri lunghi, autobiografici e volontariamente commoventi su Letterboxd. Il film in questione era Compagni di Scuola di Carlo Verdone.
Per forza di cose, un film che parla di rapporti tra vecchi compagni di liceo porta inevitabilmente ricordi diversi in base alla propria personale esperienza.
Con How To Have Sex è successa più o meno la stessa cosa. Per ragioni decisamente più deprimenti, ma comunque vere.
L’adolescenza fa schifo, quando sei uno sfigato. O meglio, è divertente quando pensi ai momenti condivisi con gli amici che erano sfigati esattamente quanto te, ma al di fuori della cerchia, specie se sei toccato da una certa sensibilità, le cose non vanno molto bene.
Perché la società di oggi ci ha imposto che se sei in ritardo, per qualsiasi cosa, conti meno di qualcun altro. Succede con la laurea, con gli obiettivi lavorativi, ed è una cosa ancor più incisiva quando si parla di sesso.
Chi ha vissuto un percorso di più lenta emancipazione sessuale, sa quanto questa enorme mancanza travolga in maniera tale da far sentire emarginato. Sa anche quanto questo costante sentirne parlare non faccia che indurre a credere che quella cosa, questo passaggio, questa esperienza, possa non arrivare mai.
Sentire parlarne tutti, come in uno stereotipato cerchio da associazione di sostegno contro le dipendenze. Ma dove, al momento del proprio turno, ogni finzione svaniva, ogni scusa si distruggeva in mille pezzi, finendo per somigliare ad uno che si era infiltrato lì per chissà quale, buffo e a tratti straniante, motivo.
La spudorata verità è che un film così va affrontato proprio da questa posizione, quella di un patimento nei confronti dell’esperienza sessuale. È questa, la volontà della sua narrazione, e credo fosse questa l’intenzione della regista: trasmettere questo senso di insicurezza, di confronto con i rapporti fisici come convenzione sociale e non come passaggio di crescita.
Eppure, il risultato finisce per diventare un racconto colmo di stereotipi e con nulla di davvero profondo.
Tre migliori amiche, Tara Em e Skye, vanno in vacanza. Sono eccitate all’idea di poter vivere delle giornate totalmente spensierate. Ubriacarsi, ballare fino a notte fonda, e ricominciare tutto da capo il giorno successivo.
Tara è l’unica delle tre a non aver ancora avuto un rapporto sessuale, e la cosa le pesa profondamente. I motivi li conosciamo tutti, e sono stati elencati anche nei paragrafi precedenti.
Fanno amicizia con un gruppo dell’appartamento accanto. Badger e Paddy sono l’espressione più british del maranza. Tara si invaghisce di Badger, ma lui sembra molto refrattario. Ma questa cosa del sesso a Tara pesa, così si regala a Paddy, ben meno sensibile e decisamente più edonista. Le cose non vanno come spera: tutto accade in un attimo e non è come Tara se lo aspettava. La grande occasione è sfumata, e forse sorge in lei l’idea che un’attesa sarebbe stata meno vana.
C’era questo bellissimo saggio di Umberto Eco dedicato alla bruttezza, o meglio al modo in cui la concezione che l’essere umano ha del “brutto”. È molto interessante perché si occupa di elencare i sistemi con cui, nel passato, brutto serviva a denunciare un sistema. Con gli anni delle avanguardie, però, il brutto è diventato un metodo di ricerca dell’effetto, prima con il kitsch, e infine un criterio atto a descrivere l’elemento curioso di un sistema apparentemente positivo. Così è nato il termine camp per riferirsi alla eccentricità della comunità omosessuale: brutto per gli altri, ma non per NOI altri. Una rivendicazione, politica e sociale.
Ecco, il problema di How To Have Sex è proprio questo: non c’è niente di brutto. Mi spiego meglio; sono brutte le azioni, le dinamiche, gli sviluppi (e come dire il contrario), ma è l’atmosfera a non esserlo, e tanto meno i personaggi.
Sono tutti belli, dai tratti borghesi, ben integrati nella società. Vivono due settimane in un residence chiaramente di lusso. Frequentano posti dove non si sentono mai a disagio.
È vero che, quando si parla di sesso, si parla anche di un bisogno ossessivo di affrontare l’esperienza il prima possibile solamente per compiacere l’aspettativa sociale, ma qui tutti sembrano usciti da uno spot di un qualsiasi brand di moda. Fanno tutti cose alla moda, sono tutti vestiti alla moda. Il belloccio tutto tatuato è lo stereotipo assoluto del belloccio tutto tatuato.
Anzi, a dire il vero, tutto il film sembra una mega pubblicità da agenzia di comunicazione per promuovere uno di quei viaggi organizzati per giovani maturandi, che per pulirsi la coscienza spara il messaggio da campagna di sensibilizzazione sul sesso sicuro.
In poche parole, quel vero, spudorato disagio di sentirsi fuori luogo non arriva mai. Questi ragazzi sono troppo belli, e i belli non hanno problemi, al massimo si lamentano di non averne abbastanza. Si annoiano con la consapevolezza che tutto quel che serve è a portata di mano.
Non so se la regista abbia voluto costruire un confronto tra questa bellezza stereotipata del cosmo delle mete di villeggiatura per giovani, e l’idea che anche quando tutto è perfetto il mondo è terribilmente opprimente, con i suoi obblighi sociali. Se questo era il nobile intento, forse per me non ha funzionato e basta.
Ciò che accade all’interno del film è orribile, quello che accade alla protagonista è orribile. Ma è come se quell’orrida rappresentazione somigliasse più alla volontà di scandalizzare a tutti i costi, piuttosto che indagare sul perché a volte ci si butti in un’esperienza soltanto per il piacere di poterla raccontare.
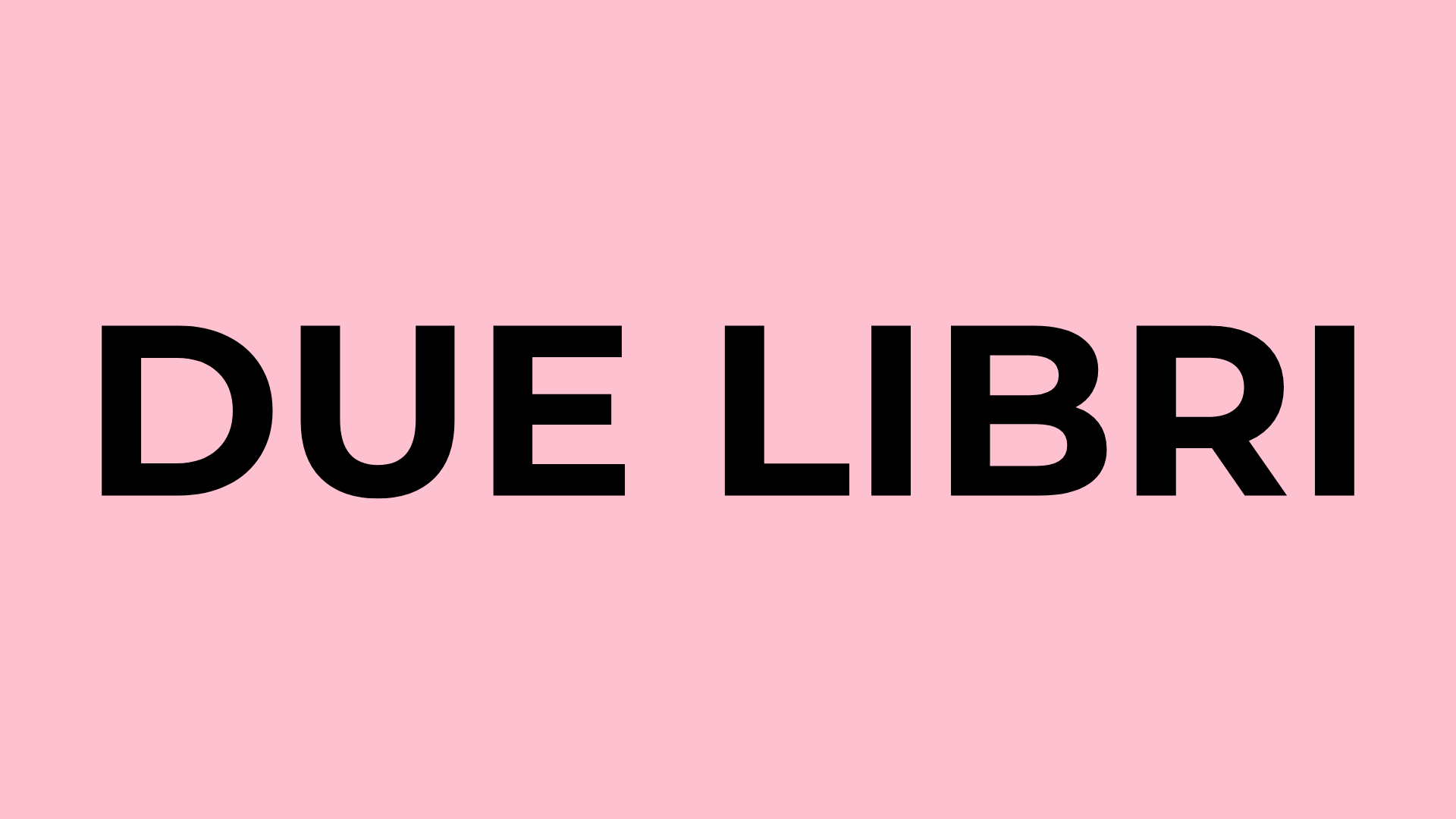

Lascia un commento